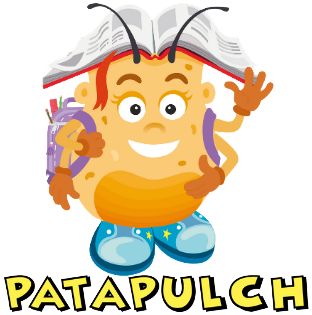ABE
Abecedario di Eboli (Salerno) 9. Genealogia, cognomi e toponomastica: Locum Eboli, Civitate Eboli e Castello Evoli con S.Lorenzo al Castello e loco Francavilla
Arturo Bascetta
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 166
Senza mescolare troppo fra loro i vari toponimi di luoghi diversi chiamati 'Eboli', onde evitare confusioni, volendo però tracciare un minimo di percorso storico come prologo alla descrizione dei luoghi citati ufficialmente nel 1700, abbiamo voluto riportare qualche riferimento relativo alle pergamente dell'Archivio di Cava e dell'Archivio di Montevergine, vere o false che siano. Pertanto, già nell'anno 869 dopo Cristo, si ha notizia negli atti della originaria Badia di Cava, quella sita in Loco Mitiliano, di un primo toponimo riferito ad Eboli, cioé de Locum qui Eboli nuncupatur. Andato distrutto questo primario luogo abitato a causa delle continue guerriglie longo-normanne, sempre prendendo per veritiera la pergamena, i suoi abitanti si ritrovano trasferiti in un Castello, quindi in un luogo diverso. È la fortezza che nell'aprile del 1047 viene citata parlandosi di un ristretto ecclesiastico dipendente da Cava, plures rebus staviles foris Castello Evoli che comparirà anche come feudo, nel Catalogo dei Baroni, che, diversamente da altre interpretazioni, andrebbe datato 1092. Passati i suoi signori feudali al seguito di Federico II di Svevia, nel 1219, Eboli fu accolto nel Demanio Regio. Quando giunsero sul posto i monaci di Montevergine, nell'anno 1221, lo fecero per costruire un proprio ospedale, obedientiam et hospitale Ebuli, dipendente dai verginiani per volere regio; potere che si rafforzerà anche per la nascita dell'ecclesias Sancti Martini et Sancti Blasii et hospitale pauperum cum domibus molendinis redditibus et possessionibus suis, tolti e poi reintegrati al monastero da Carlo I d'Angiò con Ecclesiam Sancti Georgi, l'orto presso Sancte Catherine, da cui la tassazione delle decime pontificie, quando si ritrovò nella nuova ripartizione territoriale del papa seguita al terremoto del 1348. Ma la prima chiesa antica del Castello di cui si ha notizia nei documenti verginiani è sicuramente quella di San Lorenzo seguita da San Bartolomeo. Tralasciando la storia antica, ci piace sottolineare come località ebolitane oggi apparentemente ininfluenti dal punto di vista geopolitico siano state nel passato considerate beni di scambio fra i primi possessori ai tempi dei re normanni. Luoghi come Gorgo e Gratalia sono infatti citati in una pergamena del luglio 1168 scritta proprio ad Eboli e poi, per diverse vicissitudini, finita nell'Archivio Storico del Monastero di Montevergine. Prima di allora, ad essere citata, quale prima chiesa nata presso i preesistenti possedimenti cavensi, è San Lorenzo. S.Lorenzo compare come per la prima volta in una cartula venditionis del giugno 1135 quando Alberada vende una casa sita intus muro de Castello Ebuli in Vico Sancti Laurentii che, nel 1163, sempre da fonte cavense, possiede sicuramente il titolo di Parrocchia, in parochia Sancti Laurentii meglio precisato in una pergamena verginiana del 1168, mantenendolo fino al 1836 quando venne trasferito alla chiesa di San Francesco dei soppressi Padri Minori conventuali. Quello del 1168 è un documento originale, il n.485, in scrittura beneventana. La pergamena fu scritta pro defensione monasterii di Montevergine riferita ad una domus, cioè una casa della Parrocchia di San Lorenzo.
Isabella l'imperatrice: sorella di re Enrico III d'Inghilterra e sposa di Federico II di Svevia: la tradizione inglese del Natale, le nozze, la reggia, la prigionia in Puglia
Sabato Cuttrera
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 178
Isabella abitò il castello di Gloucester. Nei registri quotidiani delle spese, alla data del 13 novembre 1231, venne annotato che Guglielmo, sarto del re, ebbe l'incarico di recarsi di persona alla fiera di St. Edmondsbury, per acquistare vari articoli per l'abbigliamento del suo padrone, una tunica, una sopravveste e un mantello di panno azzurro, e altri pezzi, fra cui un mantello di daino, per Lady Isabella. Il regalo di Natale fatto dal Re Enrico a sua sorella fu di tre piatti e tre saliere d'argento. Pochi mesi dopo le donò anche un calice d'argento dorato, con due tovaglioli d'altare per la sua cappella e altri arredi sacri. Le provviste per lei e la famiglia dovevano però essere fatte da due o tre uomini onesti di Gloucester. «Il Re stesso contribuì in gran parte alla sua dispensa con doni di vino e cervi, e fece anche riservare un tratto di una delle sue attività di pesca al suo uso. Le voci per Isabella sono meno frequenti nell'anno successivo. Viene menzionata due volte mentre riceveva piccoli doni di carne di cervo dal re, e arriva un ordine secondo cui Warin, il cappellano regio inviato a Isabella, riceverà un sostegno adeguato per due cavalli e due uomini per i suoi utilizzi». Tra i regali c'erano una tavola e una tavoletta d'avorio di Sardegna, che la contessa di Ponthieu aveva donato al Re, e una tavola da scacchi e pedine, custodite in uno scrigno, anch'esso d'avorio, che aveva ricevuto dal priore di Gerusalemme. Fra i regali anche 24 fasci di seta lavorata e di oreficeria, donati al sovrano da parte di Adam of Shoreditch e di altri orafi. Queste fasce erano a quel tempo, e molto tempo dopo, tra gli articoli più costosi di abbigliamento femminile, e spesso erano incastonate da gioielli di grande valore, come quelli ricevuti in occasione del matrimonio con Federico II di Svevia, quando divenne Regina e Imperatrice, seguendo il marito nelle cerimonie in Germania e in Italia, fino a ritirarsi nel Regno di Puglia. Sebbene Isabella fosse stata così a lungo lontana dall'Inghilterra, tuttavia, quando la sua vita stette per volgere al termine, i pensieri e gli affetti si aggrapparono ai momenti belli della sua giovinezza. Si dice che la sua ultima richiesta fatta al marito fosse quella di instaurare rapporti ancora più amichevoli con suo fratello, il Re Enrico III, e assisterlo con consigli paterni ogni volta che ne avesse avuto bisogno. La sua morte avvenne a Foggio, nella regione di Napoli, e fu sepolta con gli onori imperiali nell'antica città di Andria. L'Imperatore ritenne opportuno che i suoi funerali fossero celebrati in tutta la Puglia, e scrisse la seguente lettera alla magistratura della provincia: Così la lettera di Pier della Vigna: - Non siamo riusciti a sfuggire alle insidie di un nemico nascosto, poiché, dopo aver sottomesso innumerevoli regioni al giogo della nostra maestà, e mentre possedevamo pace e tranquillità, la sventura di una morte improvvisa ci ha portato via violentemente la serenissima Augusta, nata da stirpe reale. Non possiamo dunque mostrare gioia nel volto, poiché la morte del nostro consorte ci spreme una coppa di amarezza, e ci molesta e ci opprime molto. Tuttavia non siamo disposti, per l'amarezza del nostro dolore, a influenzare la nostra maestà in modo da offendere il nostro Creatore, o a lasciare che l'immensità del nostro dolore ci impedisca di conferire degnamente e con riverenza l'onore che si conviene e si addice alla nostra consorte, poiché desideriamo particolarmente che la memoria di un tale partecipe dei nostri onori sia celebrata su tutta la terra. Perciò vi ordiniamo severamente che le sue esequie siano celebrate universalmente in tutta la vostra giurisdizione, da tutti gli abitanti in ogni luogo, e principalmente dal clero e dal popolo delle città - le campane vengono suonate ovunque - affinché coloro che sono riuniti nelle chiese possano raccomanda soprattutto l'anima dell'Augusta al Dio vivente, che toglie lo spirito dei principi.
Diari di Napoli, il manoscritto di Zazzera e gli omissis inediti svelati. Storie vere di streghe, fattucchiere, poveri carcerati, femminicidi (1 gennaio-31 agosto 1616)
Francesco Zazzera, Micco Spadaro
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 152
Sono le storie di falsari di monete, feste insanguinate, Scioglimento del sangue di San Giovanni in San Ligorio, veleno al Conte di Casalduni, arrestati i Cavalieri di Malta... «Dalla cortesia del virtuoso gentilhuomo Don Antonio Savastano si è ottenuta la presente copia nel 1667 per op[e]ra dell'Ecc[ellen]za pittore Domenico Gargiulo seu Micco Spataro». Ha così inizio il manoscritto, si presume inedito non essendo stata trovata alcuna copia a stampa dell'intera versione originale, ma solo alcuni stralci che vengono messi in discussione e comparati. Gli errori e le cronache trasformate in sunti dagli storici vengono così smascherati e riportata alla realtà la sola cronaca, vera, che è poi quella copiata dallo Spadaro, grazie alla quale crealizzò dipinti fedeli ai fatti pur non avendoli tutti vissuti. Come nello stile di ABE abbiamo lasciato inalterate le cronache, riavviando la collana che descrive cosa successe, anno per anno, a far data, in questo caso dal 1616, senza manipolazioni di sorta. Migliaia di noi, luoghi e fatti sconosciuti che tornano a vivere in queste pagine di storia pura, ma anche quelli noti, arricchiti di particolari inediti, sposalizi, omicidi, banchetti, feste, sconti, sommosse, pianti e risi del popolo napoletano. Questo primo volume tratta: premessa storica di Gregorio Leti: il vicere' che sapeva tutto di tutti, le nove regole da rispettare; introduzione ai ms del copista «A» Diario del signor Francesco Zazzera, il primo anno del duca di Ossuna - ms integro; Introduzione ai ms del copista «B», le narrazioni di Francesco Palermo: L'edizione tronca, monca e modificata; introduzione ai ms del copista «C» L'istoria di Napoli dell'anonimo; gli inserti tratti dal manoscritto inedito, prologo sul 1616 I diurnali monchi di Scipione Guerra e Aspettando un governo pieno di travagli: i sei mesi precedenti di Tommaso Costo, frontespizio del copista di Micco Spataro, nota dell'autore di Francesco Zazzera: Diarij del governo del duca d'Ossuna descritti da Francesco Zazzera. Il sangue di San Giovanni alle monache di San Ligorio, pre grazia a Comite, il grano fradicio spacciato da Michel Vaaz, ricordo di Tristano Caracciolo, arresto di Ferrante Venato, banchetto regale, panegirico del Marchese di Cusano, arrivo del generale de Else e del Maqueda comandanti della compagnia spagnola, l'arcivescovo Ludovico di Bologna inviato a frenare la guerra coi Savoia, ammanco degli ufficiali del Tribunale, Vittoria de Mendoza amante del Viceré. Monete d'argento per le donne di Chiaia che si scompigliano, in gondola a Posillipo, Michele Vaaz sostenitore del vecchio Viceré, tre tempeste sul ponte del molo, successi di Milano con Toledo in Piemonte, Lorenzo de Franchi avvocato fiscale della Vicaria al posto di Gasparo Saluzzo, la morte del vescovo di Nardò, lezione al comune di Brienza, le guardie regie lasciano Posillipo e tornano a Somma, sacco del ponte donato a marinai e alabardieri.
Diari di Napoli, il manoscritto di Zazzera e gli omissis svelati. II parte 1612. Volume Vol. 2
Francesco Zazzera, Micco Spadaro
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 152
Sono le storie di liti per chi porta l'oro e il cappello di san gennaro, femminicidi dell'avaro col genero e di portocarrero, il tagliateste a corrotti cassieri di reliquie e gioielli poi tutti imbarcati per liberare vercelli dai savoia dei Seggi delle Piazze, liberato Ferrante Venato, Malore del Cardinale Sforza, negozi di Vaaz e del Marchese di Cusano scolare dei Gesuiti, che misero le mani sul panegirico di questo genero di Lazzaro mercante di veli, la vedova di Vicedomini rimaritata al Reggente Barionovi, salumi e formaggi nella dispensa dei galeotti, nozze calabresi alla figlia di Fabrizio Gonzaga col giudice Francesco d'Ocampo, querela fra i fratelli Minutillo per la nipote goduta dal cavalier Contessa con morte per veleno del Conte Sarriano di Casalduni, Marcello Lanfranco commissario di campagna favorito dalla Duchessa di Maddaloni, Cardinal Carafa va a trovare Sforza, il dottore Ottavio Stinca carcerato dal capitan Modarra, festa di Piedigrotta e ballo a palazzo coi Cardinali, ordine per Don Ottavio d'Aragona di far tagliare le orecchie a chi fece fuggire i turchi dalla galea... «Dalla cortesia del virtuoso gentilhuomo Don Antonio Savastano si è ottenuta la presente copia nel 1667 per op[e]ra dell'Ecc[ellen]za pittore Domenico Gargiulo seu Micco Spataro». Ha così inizio il manoscritto, si presume inedito non essendo stata trovata alcuna copia a stampa dell'intera versione originale, ma solo alcuni stralci che vengono messi in discussione e comparati. Gli errori e le cronache trasformate in sunti dagli storici vengono così smascherati e riportata alla realtà la sola cronaca, vera, che è poi quella copiata dallo Spadaro, grazie alla quale crealizzò dipinti fedeli ai fatti pur non avendoli tutti vissuti. Come nello stile di ABE abbiamo lasciato inalterate le cronache, riavviando la collana che descrive cosa successe, anno per anno, a far data, in questo caso dal 1616, senza manipolazioni di sorta. Migliaia di noi, luoghi e fatti sconosciuti che tornano a vivere in queste pagine di storia pura, ma anche quelli noti, arricchiti di particolari inediti, sposalizi, omicidi, banchetti, feste, sconti, sommosse, pianti e risi del popolo napoletano. Questo primo volume tratta: premessa storica di Gregorio Leti: il vicere' che sapeva tutto di tutti, le nove regole da rispettare; introduzione ai ms del copista «A» DIARIO DEL SIGNOR FRANCESCO ZAZZERA, IL PRIMO ANNO DEL DUCA DI OSSUNA - MS INTEGRO; Introduzione ai ms del copista «B», le narrazioni di Francesco Palermo: L'EDIZIONE TRONCA, MONCA E MODIFICATA; introduzione ai ms del copista «C» L'ISTORIA DI NAPOLI DELL'ANONIMO; GLI INSERTI TRATTI DAL MANOSCRITTO INEDITO, prologo sul 1616 I DIURNALI MONCHI DI SCIPIONE GUERRA e ASPETTANDO UN GOVERNO PIENO DI TRAVAGLI: i sei mesi precedenti di tommaso costo, frontespizio del copista di micco spataro, nota dell'autoredi francesco zazzera: DIARIJ DEL GOVERNO DEL DUCA D'OSSUNA DESCRITTI DA FRANCESCO ZAZZERA Il sangue di San Giovanni alle monache di San Ligorio, pre grazia a Comite, il grano fradicio spacciato da Michel Vaaz, ricordo di Tristano Caracciolo, arresto di Ferrante Venato, banchetto regale, panegirico del Marchese di Cusano, arrivo del generale de Else e del Maqueda comandanti della compagnia spagnola, l'arcivescovo Ludovico di Bologna inviato a frenare la guerra coi Savoia, ammanco degli ufficiali del Tribunale, Vittoria de Mendoza amante del Viceré. Monete d'argento per le donne di Chiaia che si scompigliano, in gondola a Posillipo, Michele Vaaz sostenitore del vecchio Viceré, tre tempeste sul ponte del molo, successi di Milano con Toledo in Piemonte, Lorenzo de Franchi avvocato fiscale della Vicaria al posto di Gasparo Saluzzo, la morte del vescovo di Nardò, lezione al comune di Brienza, le guardie regie lasciano Posillipo e tornano a Somma, sacco del ponte donato a marinai e alabardieri. Imbarco di 200 moschettieri col Di Maqueda, 300 nobili cavalieri fra i principi di Stigliano Bisignano, Conca e Avellino.
Diari di Napoli, il manoscritto di Zazzera e gli omissis inediti svelati. I parte 1617. Volume Vol. 3
Francesco Zazzera, Micco Spadaro
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 178
Sono le storie de: l'Accademia degli Oziosi del Mansi, la spia del Papa, naufragio della flotta, la lite sui resti di Bona Sforza 1200 soldati a Pavia, epidemia dalla Grecia: niente carne, il piano dei Savoia per svaligiare la banca di Amalfi. La briga di Don Carlo Caracciolo con la cortigiana Runnella frea le cause del Di Costanzo, e scontro poi per Donna Eugenia e Rotolina, poi l'infame Bambace, alias Cicco Capano, e i giochi messi al bando dal Viceré per i troppi guai commessi da Pentio Cava, Giovancarlo Magro, Tonno Prota, Costanza d'Afeltro, fra' Nastaro e l'Urbetano. Ma il carnevale di S.Antuono, mentre i Napoletani combattono con Milano su Novara, entra nel vivo con nuovi invitati ai festini regi; il dottor Ortenzio del Pozzo, il Cardinal Farmese, mentre l'avvocato del popolo Carmillo della Marra, nulla poté per salvare fra' Orazio Minutolo della scomunica e l'invenzione fasulla di Giuseppe Milano per salvare Napoli dai debiti. I regenti della Vicaria, Costanzo e Lopes aveva già sotto torchio dei consigliei Patigno e Palazzo la povera Donna Eufrasia, mentre si era pronti per far giudici il figlio del consigliere Rovito e quello del presidente Saluzzo. Ma era già Carnevale per tutti, con marchesi, principi e duchi, da Cammarota a Pompeo Brancaccio, da Camillo delli Monti a Madaluni, Conca, San Donato e Avellino, pronti a giostrare, evitando la scaramuccia di Caracciolo e Mariconda contro uno spagnolo, mentre con altri cavalieri come Saripando andavano dal Papa, applauditi dal Cardinale Borghese. Ma al pro regente Santo Iacono non stava simpatico il capitano Carlo Carafa di Bitetto. Feste, balli e canti a Palazzo, presero il sopravvento sulle messe. Ma non mancò il Cardinal Carrafa di favorire Lucio Piscicello a giudice della Vicaria al postyo di Martino, pronto alle cause di Geronimo de Guevara e Alfonso Acquaviva, e a capire meglio la rissa fra il dottore Funicella e Giacomo Di Bologna che litigò con Panarella, difensore dell'avversario. Così, mentre il Duca si godeva la Tragedia del Re Gordiano, il capitano spagnolo Francesco de Leon cadde nell'imboscata dei Maddalonesi e l'eletto di Montagna, Orazio Muscetta faceva carcerara il panettiere liberato da Golino eletto del popolo. Gennaio si chiudeva col Fra' servente de Ferraris, e gli intrecci di Sora, Mantova e Firenze per la famiglia a lutto, e Sergio Muscettola e il Barocello d'Aponte che pretendevano il prestito fatto a Luis de Toledo dal genero Conte di Pacentro corso dal Viceré, giudice supremo. Il Marchese di Cusano fa fare il panegirico al fratello e non vuole essere disturbato dal Viceré impegnato alla festa nel monastero di San Ligorio e al festino in casa del consigliere Iancono de Franchis e del consuocero Francesco Acquaviva. Obbligo di maschera e di riempire i carri di carnevale per la sfilata al Mercato con la giostra messa su da Cillo del Tufo in coppia mascherata col Duca di Torre Maggiore, ma il Cardinale Sforza arriva in carrozza fra 200 cavalieri mascherati come Peppe Milo, con la Viceregina a guidare il corteo per Via della Loggia. la festa non fermò Mastrillo e gli altri giudici contro gli arrendatori per le frodi sul vino, Gabriele de Martino, Giovan Tomase Borrello, Giovan Battista de Rinaldo, né Don Eufrasia condannata all'esilio mentre l'arcivescovo di Spalatro si dichiara antipapa in Inghilterra contro il Re con sediziosi ingegni e eresie. La Napoli è tutta presa dai canestri di galanterie, ricchi di porchette, capretti, frutti, correndo tutti, come Giacomo de Franco, a vedere la commedia e il Cavaliero del Travaglio in cartellone con l'incamiciata dei cavalli, prima delle quarant'ore di Quaresima e della causa di Giovan Vincenzo Sebastiano. Così mentre a Milano i Capitani Napoletani combattono feriti per soccorrere Crevacore, vi muore il castellano Sancio de Luna e finisce prigioniero Carlo de Sangro. Il giudice Piccolella, spinto da Giulio Mastrillo.
Isabella d'Aragona: la vedova grigia di Giangaleazzo Sforza di Milano (non chiamatemi Donna Sabetta della Duchesca di Napoli)
Arturo Bascetta
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 158
Isabella era donna coraggiosa e saggia, mentre suo marito Gian Galeazzo, se era d'indole mite e animato da buoni sentimenti, ma mancava d'ingegno negli affari. La promessa di matrimonio tra Gian Galeazzo Sforza, Duca di Milano, e Isabella d'Aragona, figlia del Duca di Calabria, alla corte di Napoli era nell'aria già da anni, e quello che si era stipulato, mentr'essi erano ancora fanciulli, «dovevasi effettuare adesso che l'uno toccava i quattro lustri, e l'altra aveva sorpassato i tre». Questo libro è la ricostruzione di quell'ambiente, fra volti e tracce di fasti, che hanno affascinato tutti gli storici che si sono imbattuti nel Rinascimento. «Il Moro aveva sul principio pensato che con questo matrimonio, mentre secondava il desiderio della dinastia aragonese, avrebbe potuto procacciare il proprio meglio. Il contratto di nozze si segnò nel Castel Nuovo di Napoli, addì 22 dicembre 1488. Subito dopo Isabella, i milanesi che erano venuti a riceverla, e la sontuosa comitiva che l'accompagnava, fecero tutt'insieme vela per Genova, per poi avviarsi verso Milano. «Inaudito» l'apparato messo su per quell'evento nazionale del 1 febbraio 1489, quando la giovane e bella napoletana fu accolta nel castello milanese per il matrimonio. I festeggiamenti pomposi erano questa volta uno scherno: Isabella si trovò infelice dove avrebbe avuto il diritto di essere rispettata e amata. E il Moro, con Isabella fosse incinta, raddoppiò la guardia intorno al Duca, quasi la tenesse prigioniera nel castello di Pavia...
Abecedario di Montemiletto (Avellino). Genealogia e toponomastica del Castrum ex Abbazia di San Pietro del Monte Aperto
Arturo Bascetta
Libro
editore: ABE
anno edizione: 2025
È vero. Nelle altre parti d'Italia i beni venivano valutati dal fisco, mentre nel Regno di Napoli si procedette su dichiarazioni di parte, con tutti gli inconvenienti (dichiarazioni orali con rivele fasulle, diminuzione della consistenza dei propri beni, negazione addirittura di possederne) che tale sistema comportava. I catasti comunali, teoricamente, avrebbero dovuto servire alle amministrazioni locali per una equa tassazione, che, al contrario, molto spesso veniva fatta gravare artificiosamente addirittura sui meno abbienti. Era necessario per ovviare a questi veri e propri soprusi che i dichiaranti indicassero tutti i beni stabili, le entrate annue di ciascun cittadino e dei conviventi. I nobili dovevano rivelare i beni posseduti nella propria terra e anche quelli in cui abitano con la famiglia e con i congiunti, facendone una breve, chiara e distinta sintesi sul margine della rivela (autodenuncia). Fine del Catasto Onciario era quello che il povero non fosse sottoposto a tasse esorbitanti e che il ricco pagasse secondo i suoi reali possedimenti. In base a questo principio i sudditi vengono tassati non solo per il possesso dei beni immobili, ma anche singolarmente per le industrie che possiedono, commercio, mestiere o arte che esercitano. Dunque, oltre all'imposta patrimoniale, restava in vigore anche la vecchia imposta personale. Infatti il focatico, l'imposta del nucleo familiare dovuto da ogni focolare, venne sostituito dal testatico, l'imposta pro capite a quota fissa, pagato da tutti coloro che non vivevano nobilmente, cioè solo da coloro che si dedicavano al lavoro manuale. Un'indagine investigativa condotta su cittadini, congiunti e conviventi, attraverso una breve, chiara e distinta sintesi sui beni immobili, e sull'attività esercitata, sulle tasse - com'è stato scritto - caratteristiche che non escludono la vivezza della enunciazione formale e la passionalità del piglio giornalistico, ogni volta che occorra, per annodare e poi snodare un sistema complesso, articolato, che appare ripetitivo e impossibile a studiarsi, che fornisce dati quasi mai letti e trascritti prima, per portare a conoscenza di noi un atro pezzo di storia mai scritta, senza entrare nel merito di punti problematici, come nello stile delle pubblicazioni promosse da questa amministrazione. Il programma della ABE, con la pubblicazione sul Catasto di Montemiletto e Montaperto, e di tanti altri volumi, ci fa entrare sempre di più nella storia di tasse e balzelli, fornendoci un lunghissimo elenco dei residenti di ogni singolo paese, dei nostri e di quelli a noi vicini. Questo aiuta i cittadini di oggi a scoprire i nomi, i mestieri e le arti dei propri antenati: l'albero genealogico di tre secoli fa! Il merito va soprattutto ad Arturo Bascetta, che si è sobbarcato, con perizia e volentieri, l'immane lavoro di una collana aperta a più collaboratori, come già abbiamo visto per i volumi pubblicati. È la meravigliosa documentazione del Catasto Onciario portata alla conoscenza diretta degli eredi di quei nonni. Interventi, studi e note di chi, con proprie capacità, intelligenza e amore per la storia locale, ha messo su carta la vera riscoperta essenziale delle radici e della storia. Che è poi la strada percorsa in questi anni da chi, come noi, ama la memoria storica di Montemiletto e del Principato Ultra. Florindo Garofalo Presidente Pro Loco «Mons Militum».
Castelfranci, il castelluccio di Baiano. Dal feudo dei franchi del milite Radulfo al borgo con la tela del Vigilante e i fabbricatori di organi
Arturo Bascetta
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 144
Bascetta si immerge nel profondo dei primi secoli dopo Cristo, fra vici e pagi delle colonie di Liguri Bebiani, disperse qua e là sulla dorsale dell'Appennino Napoletano. Parte da questi primi insediamenti coloniali, fra cittadelle tardo romane, da Cerreto Sannita a Grumento di Lucania, e spazia alla ricerca di una corrispondenza logica fra le antiche e vicine Castello dei Franchi e Monte Mariano di Boiano dei Mariani e le nuove Castelfranci di Boiano e Monte Marano rifondate dai Lombardi nel 1093, che a volte sembrano combaciare, altre volte allontanarsi completamente nei secoli. A suo dire dalla prima sarebbe nata l'altra, risalendo quei popoli il fiume Calore dal Sannio Antico di Telese al Beneventano. Ecco ripresentarsi, una dietro l'altra, le vicende dei Franchi e dei Normanni. L'arrivo dei Mariani e la convivenza con culti in opposizione al Papa portò presto allo scontro, allontanando il Pontifex Giovanni, giunto da Bisanzio, in direzione di Sala Consilina, da dove presero a risalire i monti, rifondando Conza e la sua diocesi, sottomessa al Principato. Con "Castelfranci" Arturo Bascetta, da topo di biblioteca qual è, ci consente di accedere a importanti documenti del nostro passato dei quali si sentiva la mancanza. E, nel contempo, le sue ricerche sono una vera e propria miniera di notizie indirizzate alla conoscenza e alla comprensione dei nodi più complessi della vicenda umana e politica della verde Irpinia. Il pezzo forte feudale resta quello di Bayrano, precedente e vicina a Castelfranci di Bojano, che ha a che fare con Elia dei Balbano, quando Bayrano fu disabitata con la distruzione di Giffoni. E rieccoci in Demanio Regio, nella Contea di M.Marano del Comes Elia Gesualdo di Bayrano, lontano dalla Contea arianese del Conte Giordano, con la produzione della seta fra S.Magno Alter di Pietra Pizzuta e Pinna Sancti Menna. Ora ci sono i Balbano, da Apice a Calabritto, poi riparte la Contea a Conza, fino al sequestro dei feudi di Castelfranci all'arrivo degli Svevi, quando Baiano era degli imperiali di Giffoni. Mancava un exursus su Angioini, la tassa del Focolare e il Bajuolo del comune per la via Saba Major di Cassano, e sulle tasse minori per la coniazione di moneta, adoha, stipendio per i lupari, per l'addizionale e la guerra. Questa, sembra voler dire Bascetta, è la storia di Castelfranci, Baiano, Bagnoli e Mons Maranus, che ricompaiono fra le terre del Rescritto Angioino, non è una favola, non è una passeggiata banale descritta dai viaggiatori occasionali. Questo scritto è un impegno serio, nello Stato dei Della Marra con sede a Serino, insieme a Volturara, fino a quando Castelfranci e Baiano tornano nello Stato di Montemarano, sotto i Naccarelli, e poi con i Marchesi di Mirabella, fra il 1600 e il 1700. Il volume termina con un passaggio sull'Ottocento, con la vita politica e amministrativa, le professioni, i mestieri, e i primi elettori, scelti fra commercianti e artigiani del nuovo borgo. È, questa, la vera storia di Castelfranci, un piccolo borgo con l'immenso quadro del Vigilante, le chiese e gli organi musicali costruiti dai migliori maestri di tutto il Regno.
Il palazzo badiale dei Papi beneventani a Pietrastornina (la roccia scalata da papa Leone XIII, i Lottiero d'Aquino principi toscani, i fratelli Massa, faenzari del chiostro di S. Chiara)
Arturo Bascetta
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 190
Questa seconda parte sui personaggi storici di elevata caratura che ruotano intorno al palazzo di Pietrastornina che ospitò papi, re e principi, consegna alla storia altre bellissime pagine che riguardano l'ex dipendenza beneventana. Il viaggio nella storia delle chiese del ridente paesino ai piedi della montagna del «Monte Vergene», arcipretura trecentesca dell'urbe Benevento, rinata dopo il sisma del 1348, continua con nomi altisonanti che giunsero e soggiornarono in paese. Come abbiamo già avuto modo di dire, qui si svilupparono le antiche chiese di S.Maria de Juso e di San Bartolomeo che dipesero dalla Chiesa metropolitana beneventana, oppidi sofiani da cui si distaccarono i feudi delle due Torri che diedero vita all'Università comunale del Regno di Napoli, a sostegno della tesi dell'autore. Arturo Bascetta ci accompagna per mano alla scoperta di aneddoti e piccoli episodi che coinvolgono persone e personaggi che ruotano in una miriade di località nate dallo sgretolarsi dei 36 casali cittadini. A fare da filo conduttore immaginario è la visita ad limina che a suo tempo fece l'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa, fra le chiese da ricostruire, sostando poi nel Palazzo della Collegiata di Pietrastornina dove visse la prima estate del suo trasferimento a Benevento. Il suo Diario è una fonte preziosa per conoscere i dati dell'epoca riferiti alle chiese, quasi tutte da ricostruire, come egli stesso scrive. Pietrastornina «a dì 8 settembre 1694, la chiesa arcipretale coll'altare maggiore si mantiene dalla Università, in supplemento dalle proprie rendite della chiesa. A dì 10 settembre 1694 la chiesa parrocchiale di S.Bartolomeo apostolo col suo altare maggiore: essendo rovinata questa chiesa prima dell'anno 1703 è stata trasferita la parrocchia alla nuova chiesa di S.Rocco». Il 10 ottobre 1706, il futuro Papa Orsini, attesta che «la chiesa di S.Maria delle Grazie, grancia de' padri di Monte Vergine col suo altare maggiore, si mantiene colle rendite della stessa grancia. A dì 21 settembre 1722 la chiesa di S.Rocco col suo unico altare si mantiene colla propria dote, ed in supplemento dall'Università: l'altare però colla dote assegnata dal signor Principe della Terra, patrono del medesimo» altare. Ma lasciamo che sia l'autore a guidarci in questo prezioso scrigno che si apre ai nostri occhi, mostrandoci i tesori dell'arcipretura di Pietrastornina da egli trascritti con sagacia e pazienza direttamente dalla fonte, che è il nostro Archivio Parrocchiale, in tutti questi anni di paziente lavoro. Questa seconda parte, in particolare, si snoda intorno al viaggio di una figura di elevata caratura, come lo fu quella di Papa Leone XIII, che risulta aver soggiornato a Pietrastornina in gioventù, quando era delegato apostolico beneventano. All'epoca era in via di guarigione per una malattia che lo colpì in gioventù e che lo vide spesso a riposo nelle campagne e nel paese del palazzo estivo dei papi Beneventani. In particolare, del suo soggiorno a Pietratornina, si ricorda quella volta che volle scalare la roccia al centro del paese e alta 240 metri in soli 30 minuti, nonostante le esortazioni di Don Nicola Campobasso, padre francescano del paese e discendente della famiglia titolare del Palazzo che ancora svetta sulla pubblica piazza. Sono pagine di storia da ricordare, raccontare, conservare, come nello stile di Arturo Bascetta, storico ormai di fama internazionale, i cui scritti sono presenti nelle biblioteche universitarie del mondo. Don Giovanni Panichella Parroco di Pietrastornina (Av)
Enzo I re di Sardegna imperatore mancato: l'erede di Federico II di Svevia prigioniero a Bologna
Anna Barbato, Sabato Cuttrera
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 165
Fu vestito con veste di scarlatto, foderata di vaj. Aveva in capo il diadema reale, d'oro formato, e d'argento, e ornato di pietre preziose. Una verga d'oro teneva in mano, e due copertoj si vedevano foderati pure di vaj, uno, che si vuole di scarlatto fosse, di sciamito l'altro. In cotal guisa condotto fu dal palazzo del comune fin alla chiesa di S.Domenico del tanto illustre, e ragguardevole ordine dei predicatori, accompagnatovi dai più celebri dottori di legge, e da tutti gli ordini della città. Bello era anche a vedere, come l'accompagnavano alla sepoltura i tre quarti del popolo di Bologna, e questi dei più nobili. Grande, come può idearsi ognuno, fu il concorso d'ogni sorta di persone diverse per età e per sesso, compiagnendo tutte la di lui sfortunata sorte. Egli però felice, che nelle mani cadde di sì colto popolo, e benigno, cui era ben a cuore sua persona; poiché fe d'altrui potere prigione, in tempi specialmente si barbari, che i prigioni come se rei venivano trattati; e di qualche città o popolo, di que' tanti dal padre. E, da lui, con barbare maniere offesi, non così la gli sarebbe andata. Più felice anche, se di vero cuore pentito de tanti commessi sì atroci delitti, e dell'alto dispregio, in cui ebbe la romana Chiesa, e i più sacrosanti prelati, misericordia seppe rinvenire nel cospetto del giusto Dio. Il giovane erede degli Hohenstaufen morì così a Bologna nel 1272, seguito, destino beffardo, dalla disfatta del Regno di Gallura. Per tutti, sebbene prigioniero, fu sempre il biondo Re di Sardegna, l'unico sovrano di quelle regioni che aveva abbandonato, ma che pare avesse continuato a seguire i conti portati dagli erari amministratori. Tutti gli storici concordano che Enzo non lasciò nulla in eredità, non possedendo altro che pochi spiccioli.
Otello Calbi. Rapsodia libera di un seminatore di note
Virgilio Iandiorio, Roberta Calbi
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 160
Una preziosa testimonianza quella che con evidente affetto filiale, ma soprattutto con profonda ammirazione, Roberta Calbi ci dà dell'illustre genitore a trenta anni dalla sua scomparsa. Otello Calbi «ha percorso molte strade, esplorato nuovi percorsi, un po' restando nella tradizione ma anche cercando e trovando soluzioni nuove». Mettendo ordine nei numerosi appunti lasciati dal Maestro - quasi sintetico diario di bordo - Roberta Calbi ci delinea la figura di un artista instancabile e tenace, sempre appassionato nelle sue manifestazioni musicali, fortemente impegnato nella promozione delle giovani generazioni. Una serie di flash sui momenti salienti della vita e della carriera del Maestro ci aiutano a scoprire alcuni aspetti del suo carattere. Nato in provincia di Matera approda al San Pietro a Majella per coltivare e far crescere il precoce talento musicale divenendo poi stimato docente della prestigiosa Istituzione dalla fine degli anni '50 alla pensione. Così viene ricordata la sua esperienza di docente: «allievi, prove, concerti, diffondere la musica ai giovani, valorizzare le capacità dei giovani musicisti, questo l'impegno che lo caratterizzava, costante e sempre più intenso». La "rapsodia libera di un seminatore di note" si dipana con grande piacevolezza tra le mani del lettore: si ha modo di conoscere un Otello bambino (fin dall'età di 8 anni suonava nella Banda del suo paese natale), i suoi rapporti con il padre e i fratelli musicisti, le sue frequentazioni ed amicizie - rimaste salde nell'arco della vita - ma si scopre anche un giovane studente dallo sguardo corrucciato al cospetto della storica statua di Beethoven posta nel cortile del conservatorio, un giovane e appassionato allievo di Achille Longo, Gennaro Napoli, Ennio Porrino, un autore di musica da camera e per il teatro, un padre e un marito affettuoso, un critico musicale e un saggista, un uomo di cultura appassionato di poesia… Per i musicisti della mia generazione e in particolare per quelli che tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '80 del secolo passato erano studenti di Composizione al San Pietro a Majella, alcuni nomi di docenti e compositori napoletani risuonavano particolarmente familiari: Aladino Di Martino, Bruno Mazzotta, Jacopo Napoli, Alfredo Cece, Otello Calbi … personalità che pur nella diversità del proprio sviluppo artistico, manifestavano tutte quei tratti ascrivibili ad una "comune scuola" napoletana. Con serenità e consapevolezza, ma tutti con proprie personali vedute, questi compositori non persero mai di vista l'emozione del suono (l'espressione melodica, il gusto per l'armonia…), tutto quello cioè che, con furia demolitrice, la "nuova musica" della metà del '900 bandiva dalla composizione contemporanea. La loro posizione era sostanzialmente conservatrice, estranea ad eccessi modernistici: essi attinsero consapevolmente alla musica delle diverse epoche storiche (senza escludere anche gli anni a loro contemporanei) purché risultasse utile alla realizzazione delle proprie opere e congeniale al proprio sentire artistico. Noi "giovani" di lì a qualche anno avremmo intrapreso strade diverse da quelle da loro tracciate, ma la stima e la riconoscenza nei confronti di coloro che a vario titolo contribuirono alla nostra formazione di docenti ed artisti è rimasta salda e immutata nel tempo. Al di là della diretta discendenza didattica (allievo di Aladino Di Martino, nel mio caso) tutti questi docenti e compositori hanno in qualche maniera influenzato le nostre storie e lanciato dei semi che sono stati raccolti e fatti germogliare. Sebbene abbia conosciuto il Maestro Otello Calbi di persona quando già cominciavo a muovere i primi passi da docente di composizione, nei primi anni '90 - quando il Maestro era oramai in pensione - il suo nome mi era invece molto familiare da tempo: ... Gaetano Panariello Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli
Bona di Savoia, la ducissima di Milano: l'orfanella, l'eredità degli Sforza e il voto a Firenze
Arturo Bascetta
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 132
Nobildonne, rapporti epistolari e comparaggi negli stati preunitari. Volendo dare un incipit a questo testo di storia pura, l'autore non poteva che partire dall'albero genealogico dei Savoia, rinvenuto in un manoscritto dalla copia inedita, inserito nelle ultime biografie trattate in collana. Ma non solo. Si riparte anche da Francesco, figlio del fu Muzio Sforza, capitano del Regno di Napoli, giunto da Cotignola per mostrare il suo ardire e il suo ardore verso la Regina Giovanna, portando a casa feudi e castelli dotali per sé e per i figli. Si può quindi tranquillamente affermare che gli Sforza beneventani furono cugini stretti del Duca di Milano, possedendo gli imprendibili castelli sui passi dell'enclave papalino che costarono il Regno a Re Renato d'Angiò. E' quindi da Francesco che nacque anche la progenie Sforzesca di Milano per aver saputo farsi spazio a corte, fra una cavalleria e un ammiccamento con Bianca Visconti, dalla quale ebbe tutta l'eredità degli Stati lombardi, a danno dei familiari, già sul piede di guerra. Fu questo forse il motivo per cui il piccolo Galeazzo non era nemmeno nato che la mamma provvide a lanciarlo sul mercato più vicino, quello di Mantova, designando per amata duchessina del figliolo la bella e intelligente, nonché poetessa acculturata dei Gonzaga, Dorotea dagli occhi bianchi. C'è da dire che fra i due pargoli nacque anche l'amore pure, sbocciato nell'istinto amoroso adolescenziale, fra lettere, bacini e lacrime d'amore. Accadde però che Bianca intravide nel figlio la speranza di poter presto riunire in qualche modo la famiglia Viscontea per evitare guerre, immaginando di dare il figlio, come suggeriva l'astuto e arguto marito Duca, nelle mani di ben più ricco e nobile signoria. Da qui la separazione epistolare, struggente, fra gli amanti per sospetti sulla verginità della dama dagli occhi bianchi, voltando pagina per gradimento della Padrona di Milano, affinché Galeazzo sposasse il partito Savoiardo, impalmando l'orfanella rimasta in casa del Duca Amedeo: la bella Bona. E così ecco Bona già pronta a frequentare la corte sforzesca, mentre la cognata diventa Duchessa di Calabria e la cometa di Halley non preannuncia nulla di buono: solo il sisma e la peste. Ma Galeazzo è l'erede e Bianca è la sposa, anche se non piace a tutti in Casa, che Amedeo di Savoia gli porta sull'altare il 6 luglio 1468. Da qui l'amicizia fra casate sempre più influenti degli Stati Italiani preunitari, arrivando a Firenze, per raggirare le difficoltà sopraggiunte a Napoli. Ma se mancano i soldi l'astuzia di Bona provvederà a trovarli. Le lettere con Lorenzo de' Medici rappresentano la prova della corrispondenza privata fra le famiglie al fine di ottenere soldi, tanti soli, in prestito certamente, offrendo banchetti e battesimi di comparaggio, e le insegne ducali. Spunta così il voto fatto da Bona alla Madonna di Firenze e il viaggio organizzato dal marito, con pifferi, musici e poeti, con l'intera corte milanese al seguito, il tutto in onore della moglie. Il programma fu impostato per aprile del 1471 e uno stuolo di nobili timorosi dell'invasione veneta e affamati di potere entrò in Firenze il 1 maggio, per la sfilata delle carrette milanesi. Festa fatta, prestito avuto, alleanza stretta, non resta che tornare a casa per la via di Lucca, Genova e Pavia, donando qualche Terra faentine ai nipoti di Papa Sisto e sedendosi a tavolino per passare a stringere nuovamente i rapporti con i Napoletani. Stavolta sarà il biondo e virile Giangaleazzo a sposare Isabella d'Aragona, riportando soldi e allegria in Casa degli Sforza e dei Savoia, prima del terribile epilogo che quattro anni dopo insanguinò la Basilica di Santo Stefano a coltellate, strappando a Donna Bona l'amato figliolo.