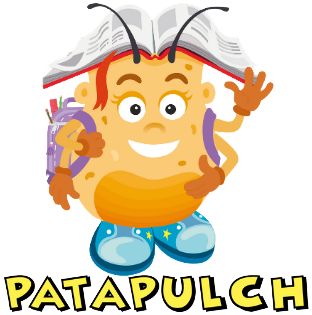ABE: I cartonati
Cronache dei tempi miei. Volume Vol. 4
Loyse De Rosa, Virgilio Iandiorio
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2023
pagine: 148
«Non ha dato un titolo al suo libro, ma credo che se l'avesse fatto, Loise De Rosa, avrebbe intitolato il testo alla maniera napoletana di «mo, ve conto». Era il modo antico, dei nostri avi cittadini del Regno di Napoli, di richiamare l'attenzione dei presenti, perché si stava per dire qualcosa di interessante, di importante. In questi ultimi anni è stata riservata maggiore attenzione alle "cronache" degli scrittori napoletani del XV e XVI secolo. Pochi anni fa De Caprio sottolineava "il nesso fra contesti, tradizioni culturali e scelte linguistiche delle cronache in volgare". Grazie a questi contributi, possono essere individuati "alcuni temi storiografici centrali per quanti, tra Cinque- e Seicento, affidano alla scrittura storica il compito d'illustrare le ragioni della preminenza sociale e politica dei ceti provinciali: il mito delle origini greco-romane e l'attenzione al Sacro, che si declina come interesse per la fondazione eroica delle città, per il culto dei santi protettori, per le istituzioni religiose". C'è qualcosa di più in questo desiderio di raccontare le vicende a cui si è assistito o di cui rimane ricordo nella tradizione culturale. Nel XV e XVI secolo in tutti i centri abitati del Regno si concordano tra gli abitanti e il feudatario dei regolamenti della vita cittadina, regolarmente sottoscritti davanti a notaio. Sono gli Statuti o i Capitoli Municipali, con cui vengono concordati i criteri di convivenza tra le famiglie, il rispetto dei loro beni materiali e la tutela dell'ambiente. Se si concorda qualcosa, vuol dire che ai contraenti si riconosce la "persona giuridica", cioè titolarità di diritti e obblighi. Nel suo racconto Loise De Rosa attinge da un patrimonio di eventi che la tradizione popolare aveva elaborato. Prendiamo la storia dell'amore tra Alfonso d'Aragona e la bella Lucrezia d'Alagno. Dato che la storia non è menzionata nei documenti storici fino a quando essa non sarà comprovata, gli studiosi moderni continuano a discutere la natura storica di Rahel e il suo rapporto con il re. Qualche considerazione a proposito della "traduzione" in italiano del testo di De Rosa che è in "espressione" napoletana. Ho seguito quanto dice V. Nabokov sulle traduzione di un testo in altra lingua diversa da quella originaria. Ho lasciato, per quanto ho potuto, l'andamento stilistico dell'originale. "Nabokov perfezionò la sua teoria sulla traduzione letterale: precisione lessicale senza alcun compromesso a vantaggio della fluidità e dell'approssimazione metrica o stilistica. Nabokov espose le sue idee nella prefazione a Invito a una decapitazione." La fedeltà dell'autore ha la precedenza, per quanto bizzarro sia il risultato Vive le pétant e abbasso i sempliciotti, i quali pensano che tutto vada bene se viene reso lo spirito". La traduzione doveva aiutare a leggere l'originale, non a sostituirlo. Benché, a differenza del romanzo realistico, i racconti dell'oralità popolare appartengano all'ambito dell'improvvisazione, i più interessanti autori contemporanei creano l'impressione dell'improvvisazione ogni volta che, inevitabilmente, fanno uso del linguaggio colloquiale". Il testo in volgare è stato lasciato così come nell'originale, cioè senza segni di interpunzione ma solo con la divisione in paragrafi. Per chi ha letto l'Ulisse di Joice risulterà più agevole la lettura. È un poco come se De Rosa avesse anticipato il monologo interiore. Il lettore, però, partecipa all'opera dello scrittore, perché ne interpreta l'andamento della lettura e i momenti di pausa.» (V. I.)
Cronache dei tempi miei. Volume Vol. 3
Loyse De Rosa, Virgilio Iandiorio
Libro
editore: ABE
anno edizione: 2022
pagine: 144
La narrazione di Loise De Rosa non è da considerare come una cronaca fredda di eventi di cui l'autore è stato spettatore, o anche semplicemente ascoltatore. Egli, infatti, è cantore di un'epopea popolare, che canta di gesta di re e principi e di gente comune, ma secondo uno schema narrativo che si avvicina al cunto. Si comprende bene che in questo modo le storie acquistano una esemplarità vicina al sentire della gente, diventando così un esempio da seguire o da evitare nella vita di tutti i giorni. Le imprese dei re e delle persone comuni così assumono un significato morale e, soprattutto, sono la testimonianza concreta della volontà divina che si manifesta nei modi e nelle forme che vanno oltre le intenzioni dei protagonisti. Spesso egli riassume in una sentenza il significato di una vicenda. Le espressioni latine riportate sono tratte in genere dai testi sacri o liturgici. Ma come accadeva molto spesso, i fedeli che partecipavano ai riti sacri ripetevano in latino le preghiere, ma con gli adattamenti lessicali per la comprensione dei testi da parte della maggioranza di essi, del tutto o in parte analfabeti. Cosa che si verificava anche per la toponomastica locale in latino o di ascendenza latina. Per esempio, le vineae domnichae (vigne dominiche) diventavano nella toponomastica del mio paese le vigne re lo gnecche, che non è un fantomatico personaggio, ma molto probabilmente un ipocoristico, un vezzeggiativo di gno signore. Il nostro autore si cimenta in citazioni latine tratte anche da autori classici e italiani. La trascrizione incerta delle parole latine è dovuta certamente ad una padronanza della lingua non corretta, ma a guardare bene il nostro autore aveva assimilato molto della cultura delle persone con cui era a contatto.
I diurnali di Messer Teo. Giornali napoletani del 1200. Volume Vol. 1
Matteo Spinelli, Sabato Cuttrera
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2022
pagine: 128
Mancava all'appello la riunione di tutti i giornali di Matteo Spinelli in questo libro con una introduzione di Gerardo De Mattia e la premessa dello storico Giovan Bernardino Tafuri. La breve ma ricca introduzione di Giovan Bernardino Tafuri (Nardò, 1695) mette in mostra le capacità analitiche storico letterarie dell'Autore, ma non manca di esercitare un giudizio critico su chi ha rimaneggiato l'opera. Questi, attingendo alle numerose fonti in suo possesso, si accinge a rettificare gli eventuali errori di chi, vista anche la fama dei Diurnali, si è cimentato nell'attività di trascrizione, diffusione e magari di 'correzione' del testo, soprattutto nelle date. La narrazione prende il via nel 1247, anno del ritorno di Federico II dalla campagna lombarda, e pone un accento particolare sull'amministrazione giuridica dell'imperatore, tra difficoltà economiche per stanziare una nuova impresa militare e un delicato equilibrio politico da mantenere. Essa prosegue riportando le gesta di Re Corrado, in aperta opposizione al papato, muovendo guerra a quei baroni, avidi di potere e autonomia, che avevano alzato le bandiere papaline. Il fine ultimo del sovrano è quello di recuperare il controllo di Napoli, cinta d'assedio e presa senza risparmiare alla città fame e sofferenza. Nel vorticoso susseguirsi degli eventi, alla morte di Corrado, emerge e risalta la figura di Manfredi, abile diplomatico e amministratore, a volte precursore rinascimentale, da Principe di Andria a Re di Sicilia, Matteo Spinelli ci restituisce il ritratto complesso di una figura emblematica dalle molteplici sfaccettature. Lo Svevo viene presentato come amante della cultura, desideroso di conoscenza e uomo dedito ai piaceri dell'arte, perfino consapevole del valore della storia, tanto da voler lasciare ai posteri, in suo ricordo, una città col proprio nome. La fabbrica di Manfredonia, invece, ancora una volta è l'ombra di una disfatta che oscura le speranze del reggente-vicario. Il reame è del papa e Manfredi non ha il potere ecclesiastico, che dà manforte alla casata Angioina. Il nemico, Carlo I, si appresta ad una crociata sanguinosa contro la dinastia Sveva, martoriando il Regno di Sicilia che difficilmente troverà pace. I Giornali di Spinelli vanno letti d'un fiato, senza badare troppo alle date, quanto ai contenuti, e a quei particolari sfuggenti, come la tempesta della Schiavonia che si abbatte sulle Marine del Principato, dove il Re accorse sul suo cavallo, quasi a voler sfidare la furia degli eventi naturali. Ecco i temi trattati: I. I parlamenti federiciani di Barletta II. Il Giustiziere per le Terre di Bari III. La morte di Federico II di Svevia CAPITOLO II I. Re Corrado assedia il Papa a Napoli II. Gesualdo, la porta di Valle Beneventana III. La Taverna beneventana di Morcone IV. La Chiesa salvò Casa Sanseverino Capitolo III I. Il Papa circuisce lo Svevo II. Manfredi suda l'eredità di Corradino III. Faro d'Ofanto, pietra miliare di Barletta IV. Da Principe di Andria a Re di Sicilia CAPITOLO IV I. Manfredonia nasce a Civitate e Siponto II. Lo scontro con le guardie saracene III. La figlia Costanza promessa sposa IV. Scaramucce fra cavalieri gentiluomini CAPITOLO V I. Le feste barlettane di Re Manfredi II. Prigione per chi violenta le donne III. La crociata papalina contro lo Svevo IV. Tenui incontri fra Guelfi e Ghibellini V. Il Conte Falcone dei Gesualdo CAPITOLO VI I. I papalini in ritirata sul Garigliano II. Il Papa nomina un Angioino a senatore III. I Guelfi consegnano Napoli a Carlo I IV. Carlo II d'Angiò detto lo Zoppo V. Corradino vuole il suo reame VI. Casteldelmonte stazione regionale VII. Cavaliere Fierimonte fu Loffredo VIII. Angioini padroni del Regno coi riscatti.