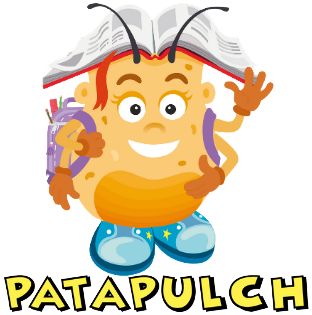Edizioni ETS: Mousai. Laboratorio di archeologia e storia delle arti
Dialogando. Studi in onore di Mario Torelli
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2017
pagine: 477
“Questo lavoro prende le mosse dall'osservazione dell'altare della Pietà di Agostino di Duccio, che lo eseguì tra il 1473 e l'anno successivo per la cattedrale di Perugia e ora in parte rimontato nel Museo Capitolare della città. In particolare, vorrei mettere in evidenza il tema della consistenza materiale del manufatto e delle sue finiture di superficie. Il dato che salta immediatamente all'occhio è quello della policromia, o, meglio, delle ampie campiture di colore ancora visibili sui bassorilievi. Leggendo, però, i documenti non c'è alcun riferimento all'acquisto, e quindi all'impiego, di materiali destinati a "colorire" i supporti lapidei.” (Chiara Basta)
Intrecci mediterranei. Pisa tra Maiorca e Bisanzio
Anna Rosa Calderoni Masetti
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2017
pagine: 118
Il libro raccoglie sette saggi. “I materiali arabi conservati a Pisa, a Lucca, a Firenze e la loro provenienza dalla conquista balearica”: sulla base della presenza nella chiesa pisana di San Sisto della lapide funebre di al-Murtadá, primo sovrano indipendente delle isole Baleari, derivante senza alcun dubbio dal sacco di Maiorca effettuato dalle milizie pisane durante la guerra balearica del 1113-1115 e non ricordata nelle fonti, l’autrice si chiede se altri oggetti islamici conservati a Pisa, a Lucca, a Firenze possano appartenere al medesimo bottino. Escludendo inoltre che queste splendide opere potessero venire immagazzinate, e privilegiando invece l’ipotesi di una loro collocazione immediata e celebrativa nel duomo pisano dopo il ritorno dalle Baleari nel 1115, individua attraverso la loro dislocazione originaria lo stato di avanzamento dei lavori nella medesima cattedrale, al momento della sua consacrazione il 26 settembre 1118. “Indagini sul falco islamico di Lucca”: la partecipazione di cittadini lucchesi alla medesima impresa e i confronti con il grifo pisano, suggeriscono di ricondurre al medesimo saccheggio il falco conservato nella basilica di San Frediano a Lucca. “Precisazioni sulla lastra ornata con tre plutei del Duomo di Pisa”: l’analisi critica e materica della lastra con tre plutei del duomo pisano invita a considerare anche questo pezzo come proveniente dal sacco di Maiorca. “Un confronto fra l’arabitas pisana e quella genovese”: il confronto con la situazione pisana consente di attribuire al saccheggio effettuato dalla flotta genovese nel 1147 ad Almeria, alcuni oggetti islamici conservati a Genova. “Draghi antropofagi sulla facciata del duomo di Pisa”: componenti di cultura islamica sono presenti nel basamento della facciata nella cattedrale di Pisa. L’anomala collocazione di opere caratterizzate in maniera analoga nella zona intermedia del frontespizio, quali i draghi antropofagi, viene ricondotta ai restauri successivi all’incendio del 1595. “La porta del duomo di Pisa proveniente da Bisanzio”: sulla base di parallelismi con la porta ageminata di San Paolo fuori le mura a Roma, l’iconografia bizantina delle scene presenti sul pulpito di Guglielmo viene collegata alla porta analogamente ageminata ricordata sulla facciata del duomo di Pisa e distrutta nell’incendio del 1595. “Fra Diotisalvi e Nicola Pisano”: la nascita a Pisa di Nicola Pisano, attestata dall’iscrizione presente sopra una formella della Fontana di Perugia, riapre il discorso sulla figura del padre, quel Pietro che nei documenti coevi è detto “de Apulia”, ma che al momento della nascita di Nicola doveva già trovarsi nella città toscana. Alla citazione di un maestro Pietro presente in un documento ricondotto dalla critica a lavori interessanti la decorazione basamentale del battistero e databili ai primi anni del duecento, viene affiancata la presenza del medesimo nome fra le due prime archeggiature della chiesa pisana di San Nicola, forse collegabile a un sarcofago o comunque a una “memoria”. Ne consegue la proposta di riportare al primo quarto del duecento, confermando il loro collegamento con gli studi di Leonardo Fibonacci, sia la parte originale della facciata della chiesa, sia il campanile corrispondente, uno dei capolavori dell’architettura medievale pisana.
Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2016
pagine: 112
I due saggi raccolti nel presente volume prendono in esame in modo sistematico i risultati conseguiti dalla ricerca archeologica svolta nel corso degli ultimi decenni da numerosi studiosi italiani e stranieri in alcuni territori della Magna Grecia abitati da popolazioni indigene. Il primo, curato da Angelo Bottini, a distanza di mezzo secolo dall'istituzione dell'allora Soprintendenza alle Antichità della Basilicata, propone un bilancio complessivo sia delle attuali conoscenze che dei temi ancora da approfondire a proposito dell'organizzazione territoriale, delle modalità insediative, delle produzioni e delle interazioni con Greci ed Etruschi delle compagini insediare nei vari distretti oggi ricadenti entro i confini della regione, in particolare per quanto riguarda i secoli fra VII e IV a. C. Maria Luisa Marchi, nel secondo, si concentra invece sui diversi tipi di relazioni instauratesi in un arco cronologico analogo fra le popolazioni italiche dell'area appenninica, identificabili con i Sanniti della tradizione storica, ed i Dauni, insediati più a sud e più ad oriente, fra Puglia settentrionale e valle dell'Ofanto; dai semplici scambi di prodotti alla transumanza stagionale, fino a veri e propri spostamenti, gravidi di conseguenze storiche, di nuclei dei primi nella terra dei secondi.
L'obolo di Persefone. Immaginario e ritualità dei «pinakes» di Locri
Elisa Marroni, Mario Torelli
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2016
pagine: 127
Nel XIX secolo lo scavo del santuario di Locri Epizefiri dedicato a Persefone ha portato alla luce oltre 1.500 esemplari, integri o in frammenti, di pinakes figurati, databili al V secolo a.C, che costituiscono un insieme unico nel variegato mondo della devozione religiosa greca di età classica. Una prima reazione a questo stato di cose si deve a Mario Torelli, che nel 1977 ha proposto un itinerario di lettura sistemica, che collocava al centro delle immagini di questi pinakes il mondo della fanciulle impegnate nella preparazione del rito nuziale. Ma a questa ricostruzione mancavano il dato quantitativo e la presentazione completa dei tipi figurati, un'opera che solo nel 2007 è giunta a conclusione con l'edizione completa delle nostre tavolette, curata da L. Vlad Borrelli, E. Lissi-Caronna e C. Sabbione. Grazie al supporto dei nuovi dati, gli autori hanno raggiunto conclusioni nuove su queste singolari rappresentazioni. In particolare Elisa Marroni ha scomposto il tradizionale quadro tipologico e ha analizzato i significati del sistema delle immagini, mentre a Mario Torelli si deve una nuova rilettura dei rituali rappresentati e un'originale ricostruzione antropologica della mentalità dei devoti e del collegato linguaggio dei pinakes, con rilevanti conseguenze di portata storica sullo sforzo, compiuto nel momento di pericolo corso dalla società tutta a causa dell'aggressiva politica di Anassila di Reggio, mirante all'integrazione dei gruppi subalterni protagonisti delle immagini dei pinakes.
Il culto dei Dioscuri in Italia. Volume Vol. 1-2
Elisa Marroni
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2021
pagine: 496
Frutto di uno studio condotto nell'ambito del Progetto Santuari antichi di area etrusco-laziale: interferenze religiose e culturali, coordinato dal Premio Balzan 2014 per l'Archeologia Classica, Professor Mario Torelli, e finanziato dal Fondo Internazionale Premi Balzan, questa ricerca è incentrata sul culto dei Dioscuri in Italia, indagato nelle sue principali manifestazioni, nell'arco cronologico compreso tra l'età arcaica e l'età imperiale romana. La raccolta delle testimonianze relative al culto dei divini gemelli, organizzate in un Catalogo corrispondente al primo volume, evidenzia un panorama di grande complessità, nel quale il culto appare diffuso in modo capillare e profondamente assimilato nel panorama religioso dell'Italia antica fin da epoca remota, spia dell'esistenza di intensi rapporti tra mondo italico e mondo ellenico, in buona parte grazie al tramite delle colonie magnogreche, ma non solo. Il secondo volume propone una ricostruzione diacronica e tematica dello sviluppo del culto, concentrandosi sui suoi aspetti fondamentali: una prima parte affronta il significato del culto in Sicilia, Magna Grecia e nell'Italia centrale, con particolare attenzione al legame con la sfera funeraria, alle tradizioni che legano le vittorie militari alla presenza dei Dioscuri sul campo di battaglia e ai rituali iniziatici dei giovani e relativi processi di integrazione nel corpo civico. Ne emerge un quadro complesso e variegato, dominato da una coppia divina ricca di sfaccettature e perfettamente adatta a soddisfare le esigenze di autorappresentazione di una realtà sociale la cui sopravvivenza era interamente imperniata sul tema della continuitas e sui meccanismi di successione. Una seconda parte del volume è dedicata invece al rapporto dei Dioscuri con le acque, nel loro legame con la navigazione, quella notturna in particolare, con la tutela delle navi in caso di tempesta, con i temi della sosta e dell'accoglienza degli stranieri. Dal loro carattere di divinità dell'hospitium e della reciprocità, un aspetto che permea in profondità la loro natura di dèi benevoli e salvifici, probabilmente origina, in un secondo momento, il nesso con la sfera della sanatio e con le divinità precipue, come Esculapio, con il quale i Dioscuri condividevano competenze mediche e benevole, ma anche, più in generale, la tutela delle categorie marginali e i relativi processi di integrazione in società. Divinità guerriere, ma essenzialmente benevole, salvifiche e garanti, i Dioscuri sono gli dèi della reciprocità e della scambievolezza, della marginalità e della possibilità di integrazione.
La colonia di Circei. Dal tardo arcaismo alla colonia di Cesare padre: santuari ed evidenze monumentali
Diego Ronchi
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni ETS
anno edizione: 2018
pagine: 176
Nel volume della "Forma Italiae" del 1928 dedicato a Circeii Giuseppe Lugli compendiò, in modo sistematico, i dati provenienti dalla sua accurata ricognizione con l’edito disponibile. Se i meriti di questo lavoro monumentale sono innegabili, questa sintesi tuttavia sigillò, con un aspetto uniforme edin certo modo definitivo, numerose questioni ancora aperte e meritevoli di approfondimento. Da questo spazio interpretativo lasciato aperto dalla "Forma Italiae", e dalla necessità di un’integrazione del materiale edito ormai quasi un secolo fa, nasce l’opportunità di questo contributo. L’autore, partendo dalla constatazione che, il più delle volte, l’identificazione tra luoghi menzionati dalle fonti e siti identificati sul terreno è stata ottenuta adoperando indizi modesti e non univoci, dedica la prima parte del contributo all’analisi delle informazioni e degli strumenti adoperati per proporre tali identificazioni. Il volume, prima di offrire una lettura diacronica di insieme, discute individualmente le grandi tematiche che caratterizzano il popolamento antico del territorio: il suo contesto mitologico, la sua edilizia religiosa e le principali arterie di comunicazione. Questo approccio ha permesso numerose nuove acquisizioni tra cui l’identificazione di un santuario dedicato a Venere, la definizione della cronologia e delle modalità di recezione dei maggiori culti locali, l’individuazione di una colonia dedotta al Circeo dal padre di Cesare e la ricostruzione diacronica dei sistemi di viabilità egemone e di navigazione interna che legavano la colonia al resto del Lazio. Il volume è l’esito di vari anni di indagini archeologiche condotte al Circeo in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, e dell’esigenza di integrare le nuove evidenze con l’edito ed i materiali d’archivio. Da questo sforzo di sintesi emerge, vivida, l’immagine della piccola e antica colonia di Circeii, le priorità della sua élite, e le risposte che vennero date all’incalzare degli eventi nel periodo compreso tra la fine del VI secolo a.C. e i primi anni dell’impero.