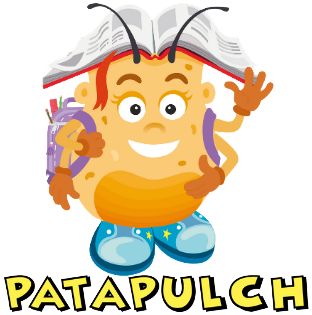Libri di Francesca Monateri
La forma romanzo. Tra Schlegel e Lukács. Con un inedito di György Lukács
Francesca Monateri
Libro: Libro in brossura
editore: Morcelliana
anno edizione: 2025
pagine: 192
Se i generi letterari esprimono da sempre il senso di un'epoca storica, il tramonto dell'epica classica solleva una domanda cruciale: quale genere può rappresentare la modernità? Consapevoli che l'equilibrio dell'antichità è ormai perduto, i primi romantici – Friedrich Schlegel, Novalis, Jean Paul e Ludwig Tieck – vedono nel romanzo il luogo privilegiato in cui l'arte non imita ma rispecchia la realtà, trasformandola. Tale questione torna nel Novecento in autori come Walter Benjamin, György Lukács e Hans Blumenberg, ridefinendo progressivamente la portata teorica e politica della letteratura. Il volume – che si conclude con la recensione di Lukács a Romanticismo politico di Carl Schmitt – ricostruisce questa vicenda e, contro le letture più diffuse, indica in una rinnovata prospettiva lukácsiana la centralità del concetto di forma (letterario, estetico e politico) nell'interpretazione di un'epoca storica.
Schmitt romantico. Letteratura, mito, avanguardie
Francesca Monateri
Libro: Libro in brossura
editore: Franco Angeli
anno edizione: 2024
pagine: 282
Un nesso multiforme lega il giurista tedesco Carl Schmitt alla letteratura, alla critica letteraria e, più in generale, all'estetica. Da Hugo von Hofmannsthal all'artista Dada Hugo Ball, passando per i poeti Theodor Däubler e Konrad Weiss, fino ai pittori Emil Nolde, Werner Gilles e a tanti altri, Schmitt si confronta con molte delle personalità artistiche più significative della sua epoca. In opposizione all'ideologia conservatrice, il professore di diritto si rivela un pensatore eccentrico, rifiutando l'accusa di degenerazione mossa dal nazionalsocialismo all'arte contemporanea. È il terreno per una rilettura essenziale del suo testo del 1919 sul movimento romantico, troppo spesso trascurato. Indagando l'influenza che le Avanguardie artistiche esercitarono sul suo pensiero, l'autrice sottolinea come la riflessione di Schmitt su arte e letteratura non costituisca un elemento marginale, ma rappresenti il cuore stesso della sua posizione storico-politica. Emergono così questioni significative anche per il mondo contemporaneo: la mescolanza di estetica e politica rischia di alimentare sempre forme reazionarie, oppure è possibile trasformare positivamente quella relazione? E cosa può significare per la politica e per l'estetica?
Katechon. Filosofia, politica, estetica
Francesca Monateri
Libro: Libro in brossura
editore: Bollati Boringhieri
anno edizione: 2023
pagine: 208
Il katechon è «la questione di fondo» di tutta la teologia politica: così scriveva Carl Schmitt a Hans Blumenberg nell'ottobre del 1974. L'enigmatica figura del katechon compare per la prima volta nella Seconda lettera ai Tessalonicesi di san Paolo, dove è riferita ambiguamente a un potere che frena, a una forza che arresta. Il termine viene quindi dalla tradizione antica e neotestamentaria: ma è a partire dall'inizio del Novecento che diviene decisivo per il pensiero politico, continuando a incuriosire il dibattito filosofico contemporaneo. Perché? In quanto potere che frena e che trattiene, il katechon ha anzitutto un valore teologico: trattiene il male impedendogli di manifestarsi, e però al contempo, così facendo, allontana il giorno della salvezza, quello in cui il regno di Dio si realizzerà su questa terra dopo avere sconfitto l'Anticristo. Ma ha anche un valore politico: è una forza che allontana la fine incombente del mondo (o della storia) garantendo l'ordine e impedendo il prevalere del caos. Infine, in quanto forma, il katechon ha un valore estetico : soverchia infatti un caos sempre incombente tenendo insieme – e amalgamando – contenuti eterogenei, e costituendo un bacino di risorse simboliche e mitopoietiche di cui ogni epoca è affamata. Quella analizzata da Francesca Monateri è, insomma, una forza che non può dirsi né positiva né negativa, e la cui natura doppia, ambigua, continua a sedurre il dibattito contemporaneo. Da Walter Benjamin a Hans Blumenberg, da Erik Peterson a Ernst Kantorowicz, da Hans Urs Von Balthasar, a György Lukács, tutto il Novecento ha dialogato incessantemente con questa perturbante figura paolina, la cui ambivalenza è stata però spesso letta in termini esclusivamente positivi o negativi, tradendo così la fecondità e ricchezza filosofica di una nozione ancora in parte da riscoprire. L'autrice offre qui, per la prima volta, la mappa completa di un concetto decisivo per intendere il presente e la nostra storia.