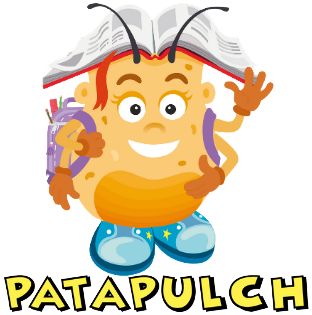Libri di Orietta Ombrosi
Il bestiario filosofico di Jacques Derrida
Orietta Ombrosi
Libro: Libro in brossura
editore: Donzelli
anno edizione: 2025
pagine: 300
«L’animale come altro»: è da questa prospettiva che Orietta Ombrosi esplora la «questione animale» nell’opera di Jacques Derrida, costruendo un bestiario – da Derrida solo immaginato – tra racconti biblici e poetici, concetti e argomentazioni filosofiche, arricchendo così la riflessione della vita reale o metaforica degli animali e delineando la nascita di un movimento di pensiero alternativo. Cercando di «allentare» la prospettiva logocentrica del discorso filosofico sull’animalità, attraverso il bestiario che l’autrice depista nell’immensa opera di Derrida, ogni animale viene a introdurre trasversalmente questioni che lo riguardano e a tracciare possibili vie, spazi alternativi o piste di indagine distinte, sebbene collegate: la sofferenza e il sacrificio, l’etica e la differenza di genere, ciò che resta della teologia e il suo legame con il politico, la politica stessa, come pure il ruolo della poesia nel suo dialogo con la filosofia, quello della scrittura, umana e animale che sia, sono rappresentate, come in ogni bestiario, da un animale ben preciso. Ecco, dunque l’asino, il gatto che è una gatta, e poi un cane dal nome proprio; ecco l’ariete e il lupo, e anche una piccola colomba; senza dimenticare il serpente, la bestia che è già sin dall’inizio. Su questo ricco mondo animale, infine, planano senza sosta le grandi ali dell’utopica Chimera, che raccoglie, ruggendo, il canto del gallo che annuncia quel nuovo giorno in cui le relazioni tra umani e animali saranno, finalmente, radicalmente differenti.
L'età del vivente. Per un nuovo Illuminismo
Corine Pelluchon
Libro: Libro in brossura
editore: Donzelli
anno edizione: 2023
pagine: 340
Come difendere oggi l’Illuminismo? Il suo ideale di emancipazione ha ancora un senso? In un mondo segnato dal risveglio del nazionalismo, da crescenti disuguaglianze e da crisi ambientali e sanitarie non possiamo limitarci a invocare un immutabile spirito dei Lumi. Questo libro si propone di fronteggiare il pericolo di un crollo della nostra civiltà senza rinunciare alla razionalità scientifico-filosofica, ma tenendo conto della nostra appartenenza a un mondo comune, che condividiamo con la natura e gli altri esseri viventi. Per contrastare gli anti-illuministi che mirano a ripristinare una società gerarchica o teocratica e per controbattere alle accuse dei postmoderni secondo cui ogni universalismo è in sé egemonico, Corine Pelluchon esorta a pensare un nuovo Illuminismo, il che significa ripercorrerne la storia, ma altresì lottare contro lo svilimento della ragione ridotta a mero strumento di calcolo e di sfruttamento, che si è tradotta in un dominio sugli altri e sulla natura. Da veicolo di emancipazione, la ragione è divenuta mezzo di sopraffazione. La nuova ragione nell’età del vivente è chiamata ad ampliare l’opera di emancipazione individuale e sociale dell’Illuminismo attraverso l’apertura alla cura dell’altro e alla differenza. Ciascuno di noi, consapevole di aver ricevuto in eredità un patrimonio naturale e culturale che deve salvaguardare, e sentendo l’unione con tutti gli altri esseri viventi, può fare la sua parte per consegnare alle generazioni future un pianeta abitabile, rinnovando pratiche e istituzioni che possono promuovere un modello di sviluppo sostenibile e più equo. L’ecologia può dunque essere la forza propulsiva per un reale cambiamento: essa può, come sottolinea Orietta Ombrosi nell’introduzione al volume, «dare avvio a un nuovo approccio al mondo e certamente anche a se stessi». Prefazione di Orietta Ombrosi.
Paradosso. Rivista di filosofia. Volume Vol. 2
Libro: Libro in brossura
editore: Il Poligrafo
anno edizione: 2022
pagine: 176
«Il perdono eccede ogni possibile logica economica di scambio ed esige, da chi perdona, un sacrificio coraggioso»: in questi termini si esprime Vladimir Jankélévitch nel sostenere che perdonare significa scardinare ogni rapporto tra colpa e punizione. Dopo le catastrofi storiche e umane del XX secolo, il tema del perdono si inserisce nella riflessione filosofica in maniera cogente mettendo in evidenza i limiti e le responsabilità del pensiero occidentale per il suo coinvolgimento in quel capitolo di storia. Oggi la questione riemerge in tutta la sua urgenza. In questo momento storico i morti – per guerre, indifferenza, pandemia, pena di morte perfino – non cessano, nel loro silenzio, di rivolgere un appello alla coscienza dell’Occidente e alle coscienze di noi tutti; eppure, attraverso questo stesso silenzio essi non smettono di accordarci “qualche cosa” di molto simile al perdono. Sulle tracce di Dostoevskij e dei grandi filosofi del Novecento, che forse più di altri, per necessità storiche, si sono interrogati sulle sfide, sui paradossi, sulle ambiguità del perdono, si cerca qui di coglierne filosoficamente il senso o il non-senso o, meglio ancora, la pluralità di senso.
Il nucleare. Una questione scientifica e filosofica dal 1945 a oggi-Nuclear power. A scientific and philosophical issue from 1945 to today
Libro
editore: Mimesis
anno edizione: 2020
pagine: 314
"Dopo" i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki del 1945, in cui l'utilizzo della bomba a fissione nucleare fu intenzionalmente distruttivo, il panorama storico, politico, sociale e culturale è radicalmente, ovvero epocalmente, cambiato. Ma un filo rosso lega il dopoguerra all'oggi: una matrice comune di inquietudine e un simile asse interrogativo sembrano rinascere. Che cosa si deve pensare della catastrofe nucleare "dopo" Hiroshima e Nagasaki? Che cosa resta di quella che dai contemporanei fu definita un'"apocalissi"? Inoltre, che dire dell'utilizzo civile del nucleare? Cosa rimane di Chernobyl e del "dopo" Chernobyl, di quell'incidente del 1986 che oramai è quasi solo un ricordo sinistro? Come comprendere il disastro di Fukushima del 2011, ancora più problematico perché sviluppatosi in una centrale nucleare ma generato da due catastrofi naturali, un terremoto e uno tsunami? Tali nomi e luoghi, legati in modo esplicito o implicito al "nucleare", sono da intendersi come dei momenti storici essenziali in cui i confini tra uomo e natura, tra natura e tecnica, tra ricerca e responsabilità, sono messi a nudo e di fronte ai quali gli uomini, e gli intellettuali in primis, sono chiamati a ripensare radicalmente, differentemente, i loro contenuti e confini. Questo è dunque l'obiettivo del libro qui presentato: tentare di dare "intelligibilità" a quella materia incandescente, così come alle incongruenze, alle aporie e perfino ai limiti delle catastrofi stigmatizzate, direttamente o indirettamente, dal "nucleare".
Derrida-Levinas. An alliance awaiting the political. Ediz. inglese e francese
Orietta Ombrosi, Raphael Zagury-Orly
Libro
editore: Mimesis International
anno edizione: 2019
pagine: 330
Ebraismo «al femminile». Percorsi diversi di intellettuali ebree del Novecento
Libro: Libro in brossura
editore: Giuntina
anno edizione: 2017
pagine: 272
“Un'ebrea”. Così rispondeva Hannah Arendt alla domanda “chi sei?”, rivoltale quotidianamente nei tempi bui e ripresa nel 1959 per il conferimento del premio Lessing. “Un'ebrea” dunque. Lei, come tante altre. Lei, come le altre. Lei, come le donne presentate in questo libro. Ora, la prospettiva arendtiana relativa a tale condizione, situazione, imposizione - o come dire diversamente? - di essere “un'ebrea” è applicata anche alle intellettuali ebree del Novecento che sono state scelte come guide, come protagoniste o semplicemente come compagne di viaggio, ma anche come oggetto di studio di questo volume. Tale prospettiva è infatti qui utilizzata come prisma di lettura per una ricerca in comune e condivisa, volta a comprendere e a raccontare l'ebraismo nella differenza, seguendo diversi percorsi, molteplici, differenziati e singolari, sia filosofici che letterari, o semplicemente percorsi di vita, di un ebraismo declinato "al femminile". Questo libro esamina in quale modo l'origine ebraica di alcune pensatrici, scrittrici e figure femminili difficilmente classificabili abbia caratterizzato non solo le loro vite e i loro destini durante le guerre, l'esilio, le persecuzioni, lo sterminio e nel "dopo", ma come tale origine abbia anche segnato i loro percorsi intellettuali, spesso radicalmente diversi, fin dentro la scrittura delle loro opere. Allo stesso tempo, esso si propone di accostare e studiare queste autrici a partire dal punto di vista della differenza, ovvero, non tanto, non solo a partire dalle lotte per il riconoscimento della differenza sessuale e dei suoi diritti ma, soprattutto, più problematicamente, a partire dalle lotte per il riconoscimento della differenza in quanto tale. Esso si interroga quindi sul modo in cui la condizione di essere donne, di essere magari anche donne differenti e nella differenza, le abbia perfino guidate nelle loro riflessioni e nelle loro scelte di vita, a volte esplicite e di adesione, altre volte più implicite e critiche o addirittura di radicale rifiuto proprio nei confronti dell'ebraismo. In quanto donne e in quanto ebree, queste intellettuali hanno dovuto necessariamente confrontarsi (anche per la via negativa), a volte senza volerlo, con la loro nascita, con la loro appartenenza a una comunità e a un genere. In particolare, hanno dovuto ripensare, riformulare, ridire, perfino rinnegare, disdire o decostruire l'ebraismo stesso, con un'attenzione, una sensibilità e intelligenza tutte femminili, così come hanno dovuto necessariamente confrontarsi, nelle loro vite e nelle loro opere - opere nutrite di vita - con la storia, fino a farne materia del loro agire, pensare, scrivere.
Il crepuscolo della ragione. Benjamin, Adorno, Horkeimer, e Levinas di fronte alla Catastrofe
Orietta Ombrosi
Libro: Libro in brossura
editore: Giuntina
anno edizione: 2014
pagine: 171
"Pensare il disastro" è l'ingiunzione di un pensiero che si confronta con la Catastrofe che si è abbattuta sugli ebrei d'Europa durante il periodo hitleriano. "Pensare il disastro" significa, da una parte, comprendere perché la Shoah ha potuto prodursi proprio in una Europa civilizzata, cresciuta sull'ideale della ragione dell'uomo, sui valori del progresso e dell'illuminismo; dall'altra, significa pensare la possibilità di un avvenire per la filosofia. Infatti, i filosofi del dopo Catastrofe non possono esimersi da questa interrogazione critica e radicale: è ancora possibile fare filosofia? Se sì, come pensare filosoficamente? T. W. Adorno, M. Horkheimer e E. Lévinas - ma anche W. Benjamin e sebbene prima dell'ora - hanno avuto il coraggio, la forza, l'acume, a volte solo la disperazione, di pensare ciò che è accaduto. Mossi dall'indignazione e dal desiderio di testimoniare, hanno sentito l'urgenza di confrontare il loro pensiero con il grido d'agonia dei morti di Auschwitz. E chi scrive, di mettersi in ascolto proprio di quello. Prefazione di Catherine Chalier.
Tra Torah e Sophia. Orizzonti e frontiere della filosofia ebraica
Libro
editore: Marietti 1820
anno edizione: 2011
pagine: 434
Il libro ha l’intento di presentare il dibattito filosofico contemporaneo sul tema del rapporto tra l’«ebraico» (Torah) e il «greco» (Sophia), raccogliendo i contributi delle voci più autorevoli, ma anche inedite, tra gli specialisti di filosofia ebraica. Si tratta di un dibattito poliedrico che cerca di interrogarsi sulla possibilità di una traduzione in greco della Torah e sulla possibilità di un «luogo» altro per la filosofia che nasce come Sophia. Si vuole stabilire se, e secondo quali modalità, è possibile parlare di «filosofia ebraica». Infatti, è da distinguere dal «pensiero ebraico» in senso stretto, così come dalla tradizione filosofica che si vuole «greca»? In che modo si inserisce nella storia della filosofia? È una filosofia della religione e di una in particolare? Si vuole qui proporre un libro che affronta, secondo una prospettiva teorica, il binomio «greco-ebraico», la loro traduzione e tensione sempre viva, l’ospitalità di una tradizione di pensiero nei confronti dell’altra. Un libro che medita sulla la complessa relazione che unisce e separa questi due grandi orizzonti, cercando di delimitarne i confini, di fare incrociare le loro vie, di percorrere quelle strade che portano da Atene a Gerusalemme e viceversa.
L'umano ritrovato. Saggio su Emmanuel Lévinas
Orietta Ombrosi
Libro: Libro in brossura
editore: Marietti 1820
anno edizione: 2010
pagine: 320
Per Lévinas, come per la sua interprete, il "fiasco dell'umano", che è anche il fiasco di una certa razionalità, ha condotto, quasi come una prova necessaria, a ripensare da capo - magari grazie al recupero di una tradizione antica -, a pensare "altrimenti" il senso, l'umano, l'uomo, la donna, la trascendenza, Dio, la ragione, la filosofia, la storia, la pace. Sotto l'urgenza di questo "fiasco"e della "crisi del senso", Lévinas sollecita così ad abbandonare l'essere, il Medesimo, la positività che rende possibile "la terra salda sotto il sole": è tempo infatti di abbandonare la terra ferma, sicura o disillusa che sia, la terra che resta solida benché lacerata; è tempo di dire "addio al mondo, alla presenza, all'essenza"; è tempo di considerare e di considerarsi il/nel passaggio, l'/nell'esilio, l'/nell'esodo, il/nel "disinteressamento". Nel lascito. È tempo, in questo addio, di ritrovare l'umano.