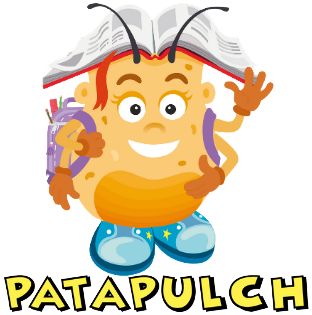Libri di Castrenze Minasola
Il patto triumvirale tra Cesare, Pompeo e Crasso (60-53 a.C.): dalla sua genesi politica ai suoi effetti sulla costituzione romana tardo-repubblicana
Castrenze Minasola
Libro: Libro in brossura
editore: Aracne (Genzano di Roma)
anno edizione: 2025
pagine: 188
Intorno al 60 a.C., i tre più potenti uomini della Roma tardo-repubblicana, Caio Giulio Cesare, Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, stringono un patto di reciproco sostegno, per non ostacolarsi a vicenda (cfr. Suet. Iul. 19.2) e così controllare occultamente le istituzioni repubblicane. Con un nuovo approccio ricostruttivo delle fonti e dei rapporti tra i triumviri, il presente lavoro mira ad evidenziare la rilevanza costituzionale del cd. I Triumvirato, tentando per questa via un "riscatto" dall'impostazione tradizionale che lo confina in una dimensione meramente politica. Dalla suddetta coalizione tra Cesare, Pompeo e Crasso si generò, quindi, quella che le fonti antiche chiamano societas potentiae (Vell. Pat. 2.44.1): una potente coalizione di forze politiche, militari e finanziarie, di cui i tre triumviri erano la massima espressione, che mise in "scacco" l'opposizione degli optimates e, per un settennio (60-53 a.C.), governò più o meno occultamente la repubblica romana a costituzione invariata (Plut. Caes. 13.4), cioè senza mutare, con esplicite riforme, le strutture costituzionali centrali. Fu sfruttando la perdurante rivalità tra Pompeo e Crasso, i due più potenti uomini della Roma tardo-repubblicana, che Cesare, al tempo meno ricco e meno potente di loro, con abile manovra politica, li conciliò in un'unica alleanza, "bilanciando" le loro forze e la loro rivalità a suo vantaggio e diventando "l'ago di tale bilancia". Si evitò così una possibile nuova guerra civile tra Pompeo e Crasso, assicurando, altresì, una certa stabilità al sistema politico-costituzionale, tuttavia strettamente condizionata dai delicati equilibri personali tra i triumviri, in particolare quelli tra Pompeo e Crasso, che Cesare dovette di fatto ricomporre nuovamente a Lucca nel 56 a.C. Numerose leggi furono così varate in attuazione degli accordi triumvirali del 60 a.C. (leges Iuliae agrariae, lex Iulia de publicanis, lex Iulia de actis Gn. Pompei confirmandis, plebiscitum Vatinium de imperio C. Caesaris) e di quelli di Lucca del 56 a.C. (lex Trebonia de provinciis consularibus, lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris). La morte di Crasso a Carre, nel 53 a.C., sciolse, però, definitivamente il I Triumvirato. L'iniustum bellum Parthicum fu, quindi, fatale sia per Crasso sia per la sopravvivenza del I Triumvirato, tuttavia, alcune idee di quella esperienza di governo probabilmente sopravvissero, lasciando traccia nella futura azione di riforma politico-costituzionale di Cesare.
I collegia nell'antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa quae pactionem atque coniurationem aduersus rem publicam fecit
Castrenze Minasola
Libro: Libro in brossura
editore: Aracne (Genzano di Roma)
anno edizione: 2022
pagine: 376
La libertà associativa è certamente un diritto fondamentale per la migliore realizzazione degli interessi assistenziali, professionali, politici o anche solo conviviali di ogni cittadino, ma quali sono i suoi limiti e quale il difficile equilibrio tra gli interessi e gli scopi associativi e quelli dell'ordinamento giuridico generale: si è tentato in questo lavoro di dare qualche risposta attraverso l'analisi dell'esperienza giuridica romana, in primo luogo mirando ad una revisione dell'indirizzo dottrinale tradizionale che limita al solo periodo tardo-repubblicano la partecipazione dei collegia alla lotta politico-costituzionale. Seguendo, inoltre, alcuni possibili percorsi di circolazione dei principi elaborati nella materia associativa dal diritto romano, medievale e moderno, si è cercato di delineare gli elementi essenziali per un modello di responsabilità criminale dei collegia in grado di fare apprezzare la rilevanza autonoma delle condotte illecite riferibili ai collegia, nel loro complesso, rispetto ai comportamenti illeciti riferibili ai singoli sodales. Premessi, inoltre, brevi cenni alle problematiche connesse al noto principio «societas delinquere non potest», riferibile più in generale a tutti gli enti collettivi, all'esito della ricerca, si è proposto il conio di un 'nuovo' brocardo, collegium delinquere potest, come possibile sintetica e specifica rappresentazione (rispetto alle societates) della capacità a delinquere dei collegia romani adversus rem publicam, in relazione al mutevole contenuto che tale ultima locuzione (e quella connessa di utilitas civitatis) assume nel corso dell'esperienza storico-costituzionale romana.